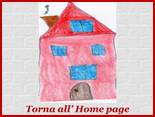Micro…riflessioni
a cura di Gabriele Giliberti
L’infinitamente
piccolo
“Un tempo gli scienziati
sapevano quasi niente di quasi tutto; oggi sanno quasi tutto di quasi niente”
(1). Una frase che rende perfettamente l’idea di come gli scienziati spinti
dalla curiosità e dal desiderio di conoscenza hanno nel tempo aumentato
esponenzialmente le conoscenze del mondo, ma al tempo stesso capito che gli
orizzonti conoscitivi si spostano sempre più lontano dalla loro portata,
rinforzando la consapevolezza che siamo ben lontani dall’aver capito tutto.
Mi dà l’idea di un uomo rinchiuso in una piccola stanza che
cerca nuovi spazi vitali, iniziando a rompere una parete, e quando ci riesce trova
una nuova stanza adiacente e dopo averne goduto per un po’ la novità, decide di
continuare nella ricerca e rompere una nuova parete, ampliando di volta in
volta la sua dimensione vitale ma contemporaneamente intuendo che il processo
non avrà mai fine e quello che all’inizio sembrava un obiettivo definitivo era
invece solo l’apertura verso la comprensione che oltre quel muro c’era un mondo
inimmaginabilmente complesso.
Meno male che Socrate non conosceva il copyright, altrimenti
oggi lo chiameremmo So©rate e suoi discendenti vivrebbero ancora di rendita,
dal momento che è da circa 2500 anni che lui sostiene la forza dell’ignoranza,
intesa come consapevolezza della immensità della non-conoscenza e come movente
del desiderio di conoscere, considerandosi l’unico sapiente, perché unico a
sapere di non sapere, di contro ai presuntuosi sofisti.
È ancora ai giorni nostri si disputa in maniera simile sul
futuro della scienza, se è vero che uno dei fisici più importanti del pianeta
come Stephen Hawking considera la conoscenza scientifica vicina al punto di
arrivo e un premio Nobel per la chimica come Ilya Prigogine la considera invece
prossima ancora al punto di partenza, di un nuovo orizzonte culturale aperto
dalla scoperta dell’instabilità dinamica e dei fenomeni caotici, che ci obbliga
a rivedere le leggi della scienza classica e a “non poter più credere a un cosmo determinato e predittibile”,
basato su “un determinismo che pone le
leggi e le condizioni iniziali” (2).
Certamente Socrate, come anche il sottoscritto, si schiererebbe
in questo secondo partito, magari senza gli eccessi metafisici descritti, ma
con la convinzione che forse è proprio questo lo spirito con cui fare scienza
oggi: avere cioè sempre la consapevolezza che ciò che si conosce non è che una piccolissima
parte della realtà, che rappresenta un’entità conoscitiva di difficile gestione
e impossibile esaurimento, e peraltro sempre interpretata da modelli soggetti
ad essere smentiti.
Sembra allora che niente è cambiato dagli albori della
tradizione filosofica occidentale ad oggi, invece qualcosa è cambiato se è vero
che oggi viaggiamo in aereo e spediamo e-mail, se è vero che anche la Terra
dopo miliardi di anni di riposo ha pensato bene di fare qualche giro intorno al
sole per mantenersi in forma e che l’acqua, sotto una spinta secessionista, si
è scomposta in H e O, e l’idrogeno a sua volta in un protone e un elettrone,
che non si sa bene ancora cosa e dove sia.
È cambiato che l’umanità ha intrapreso un viaggio verso
dimensioni nuove, di tipo razionale più che percettivo, quali l’infinitamente
piccolo e l’infinitamente grande, apparentemente agli antipodi tra loro e
invece entrambi in un’unica direzione, quella della caduta della barriera
dimensionale dettata dal nostro nudo percepire.
Un viaggio verso l’infinitamente piccolo o grande che sia,
sembra destinato a non avere fine, perché man mano che avanziamo il piccolo
sembra sempre più enorme e il concetto stesso di “piccolo” si sposta ogni volta
un po’ più in là, forse perché anche il concetto di “limite” è un limite,
un’idea dell’uomo che potrebbe non avere riscontro nella realtà fenomenica.
Questa avventura non può che sconvolgere e ribaltare il nostro
concetto di ordine di grandezza. Per me una formica è sempre stata un insetto
piccolissimo, che nemmeno vedrei se non fosse per le urla di mia moglie, però è
affascinante pensare che un atomo di idrogeno, più piccolo di circa 100 milioni
di volte, abbia al suo interno un rapporto spaziale tra nucleo e movimento
dell’elettrone paragonabile ad un campo di calcio, con al centro del campo il
nucleo (e, anche se non lo sappiamo ancora, già intuiamo che anche nel nucleo
ci sarà un rapporto spaziale simile tra un qualcosa e un qualcos’altro…); e poi
già lo vedo questo elettrone, alto più o meno un femtometro (3), che corre
sudato dappertutto in spazi sconfinati o forse è solo seduto da qualche parte
ma nessuno lo vede tale è lo spazio visivo da esplorare.
Dobbiamo forse smettere di pensare che camminare per un
chilometro è troppo e considerare che c’è qualcosa che è lungo uno yottametro,
1024 metri (una distanza che la luce percorre in 200 milioni di anni), e che
soprattutto siamo in grado di misurare, e che c’è qualcos’altro che è lungo uno
yoctametro, 10-24 metri, che viene il mal di testa solo a provare a pensare a
quanto sia piccolo, e che anch’esso siamo in grado di misurare! Chissà se la
scala degli ordini di grandezza in realtà non sia circolare e i due
infinitamente, grande e piccolo, non si incontrino in un punto adimensionale
(del resto anche la dimensione è solo una convenzione). Dobbiamo forse smettere
di pensare che una pausa al lavoro di 10 minuti è troppo corta, se pensiamo che
ci sono delle particelle, i poveri bosoni W e Z (3), che vivono mediamente
10-25 secondi, un tempo di circa 10000 miliardi di miliardi inferiore rispetto
ad un battito della palpebra (e che non credo riescano anche a fare delle
pause), e che soprattutto noi siamo in grado di misurare questo tempo! E che
dire del disordine della mia libreria, se penso che invece in 18 cm3
ci sono 1023 molecole di acqua, che se fossero fogli di carta posti
l’uno sull’altro uscirebbero dall’Universo, costrette forse a girare a targhe
alterne in una piccola immensità, come se grande e piccolo diventano quasi
sinonimi, man mano che scomponendo il piccolo ci rendiamo conto che è
incredibilmente grande e conquistando il grande ci rendiamo conto che forse è
ancora un po’ piccolo.
Risulta evidente che per misurare queste dimensioni
intellegibili e non certo percettibili, gli scienziati debbano rinunciare al
cronometro, al righello e alla bilancia e adoperare modelli, mediatori cioè tra
il campo teorico e quello empirico, sempre più astratti della realtà; e noi
osservatori e fruitori di queste misurazioni dobbiamo sempre più fidarci.
Infatti come scrive Abel Rey, docente di Storia e filosofia alla Sorbona
all’inizio del XX secolo, a proposito della fisica di Einstein, allo stadio
attuale della storia della fisica, non si può esitare a riconoscere che “la
fisica procede in modo razionale e non più sperimentale” e ancora “la scienza fisica è il bisogno imperioso e
necessario di comprendere le esperienze e renderle intellegibili” (4).
Oppure, per riprendere il pensiero di Prigogine, “le leggi fisiche corrispondono ad una nuova forma di intellegibilità”,
che presuppongono la fine delle certezze di un mondo deterministico verso un
mondo arbitrario (5). Se poi vogliamo tornare nell’antica Grecia, già Platone
vedeva nella distinzione tra la forma più bassa di conoscenza (doxa) e quella più alta (episteme o scienza) un passaggio dal
sensibile al soprasensibile, verso una forma di conoscenza basata solo sulla
pura intellezione (6).
Necessariamente il variare degli orizzonti culturali e il
dilatarsi dei margini estremi degli ordini di grandezza presuppone un
discostarsi dalla conoscenza comune, dalle dimensioni percepite dagli
organismi, sia direttamente che con i più comuni strumenti di misura, verso una
conoscenza puramente scientifica, che diventa in alcuni casi pericolosamente
fideistica. Già nel pensiero di Thomas Hobbes, filosofo inglese del XVII
secolo, veniva delineata questa distinzione tra una conoscenza “comune” o
“originaria”, fondata sull’esperienza sensibile, e una conoscenza “scientifica”
o “filosofica”, che deriva ed è rielaborazione di quella comune, proponendosi
di spiegare le cause della realtà. Una conoscenza, quella filosofica, figlia di
convenzioni della comunità dei dotti, che permette di fare previsioni della
realtà in base ad una analisi rigorosa delle relazioni causa-effetti e che
permette, sempre a detta di Hobbes, alle popolazioni occidentali di godere di
un maggior benessere, rispetto alle popolazioni di America e Africa in quanto
strumento di vantaggi pratici (3). Questo modo di sentire e di valorizzare il
metodo scientifico, nato dall’empirismo e ripreso nel Positivismo
dell’Ottocento, arriva certamente ai giorni nostri e pervade il nostro sentire
comune, che attribuisce alla conoscenza scientifica un alone di “certezza” e
vede la conoscenza comune come debole e limitata, facendoci sentire molto
piccoli e un po’ impauriti nell’oceano della conoscenza, o meglio della
non-conoscenza. Come se il variare del concetto di ordine di grandezza abbia
coinvolto anche noi stessi…
Un viaggio scientifico così intenso e veloce da mettere in crisi
l’essenza stessa della scienza che, apparentemente non bisognosa di alcuna
riflessione critica, ha invece iniziato a chiedersi chi sia o dove stia
andando, sviluppando nel corso del Novecento una intensa discussione
epistemologica sul cosiddetto contesto della scoperta (i meccanismi con cui la
scienza scopre nuovi fenomeni), della giustificazione (come gli scienziati
giustificano i risultati) e della demarcazione (tra una teoria scientifica e un
tentativo non riuscito di elaborarne una). Infatti teorie come la meccanica
quantistica e la relatività hanno ribaltato il letto di certezze
“deterministiche” su cui poggiavano gli scienziati, ingenerando delle
perplessità critiche su rapporto che le teorie stesse hanno con l’esperienza:
seguono procedure idonee ad assicurare un efficace controllo empirico oppure
sono invenzioni arbitrarie e fantastiche? La risposta è sempre più difficile,
man mano che il viaggio verso l’infinitamente piccolo e grande richiede
l’utilizzo di strumenti non più empirici quanto congetturali. E ciò fa
riflettere sulla natura stessa della scienza, vista da alcuni sempre con valore
positivo soprattutto per le potenzialità pratiche e applicative, da altri con
valore negativo come conoscenza artificiale se non alienante nella sua
specializzazione e tecnicizzazione (7).
È la riflessione epistemologica può arrivare al paradosso che
Karl Popper, uno dei più illustri pensatori del secolo scorso, può porre il
limite di demarcazione tra scienza e non scienza nella falsicabilità, dicendoci
che è scientifico solo ciò che è falso, lasciandoci nell’imbarazzo di non poter
replicare che ciò è falso, perché rischiamo di convalidare in questo modo la
sua tesi…
Ma in fondo mi chiedo dove è la certezza e dove l’incertezza;
qualche giorno fa una mia collega di lavoro, ma non addentro alle discipline
scientifiche, intervenendo in una discussione scientifica, dice “io l’unica cosa certa che so è che l’acqua è
H2O, poi non so altro”; io ho risposto “secondo me no, perché la cosa certa è l’acqua, H2O è solo
una sua interpretazione, suscettibile ad errore”. La conclusione di questa
riflessione potrebbe essere che forse, dal mio punto di vista, sarebbe
preferibile considerare distinte la scienza, intesa come teorie scientifiche in
continua evoluzione, e la realtà, come entità che percepiamo con i nostri
sensi, sia quelli personali e soggettivi sia quelli messi a disposizione dal
progresso della scienza stessa (altrimenti io senza occhiali non vedrei nemmeno
in faccia il mio interlocutore).
Lungi da me non tener conto degli effetti del progresso
scientifico e tecnologico, che si può disputare se sia costituito o meno da
verità assoluta o modelli interpretativi variabili e falsificabili, che a volte
deve fronteggiare accese controversie e slittamenti di paradigmi di
riferimento, tanto per citare Thomas Khun (3), ma che è certamente tangibile e
che ci ha cambiato la vita, spesso migliorandola.
Ma se anche un certo Albert Einstein pensa che “I concetti della fisica sono libere
creazioni dello spirito umano, e non sono, nonostante le apparenze, determinati
unicamente dal mondo esterno”, allora mi piace pensare che la realtà
fenomenica sia sempre quella percepita dai nostri sensi: che per quanto
sappiamo che è una serie di reazioni termonucleari di fusione dell’idrogeno,
consideriamo il sole come una romantica palla infuocata; che per quanto è utile
farci qualche radiografia, continuiamo a pensare che le radiazioni sono solo
quelle che vediamo nell’arcobaleno; che per quanto i miei canarini a volte
iniziano a fischiare nervosamente e di concerto, continuiamo a considerare che
quando non sentiamo niente, vuol dire che c’è silenzio; che anche se sappiamo
che un elettrone è lungo un femtometro, per noi un millimetro continua a essere
piccolissimo; che anche se ci hanno convinto del contrario, a noi la Terra
continua a sembrarci ferma ed è il Sole che sorge a levante per tramontare a
ponente. Mi piace pensare ad una realtà che rimette noi stessi al centro
dell’universo percettivo, lasciando la scienza a girarci intorno, anche quando
ci sembra vera e quando ci fa vivere meglio, e che rimette al centro della
scala degli ordini di grandezza, quelli a noi più familiari.
Ma la conclusione è anche un’altra, e cioè che a volte è molto
utile per aprire la mente e vedere le cose da tutti i lati piuttosto che sempre
dalla stessa facciata, oltre che piacevole, fermarsi a riflettere su quello che
si fa e sul suo significato (perché in fondo la scienza è il mio lavoro).
Ma se per Victor Hugo “L’amore
vero si dispera o va in estasi per un guanto perduto o per un fazzoletto
trovato, e ha bisogno dell’eternità per la sua devozione e le sue speranze. Si
compone insieme dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo.”,
non sarà per caso che alla fine della storia sentimento e scienza siano simili
e possano andare d’accordo?
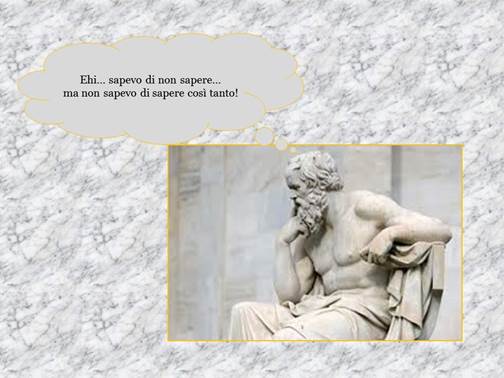
Riferimenti bibliografici:
(1): Prof. Vincenzo Balzani, docente di Chimica generale,
Università di Bologna. Il Consiglio Europeo delle Ricerche: La ricerca di
frontiera. Bologna, 20 giugno 2006.
(2): Il tempo come principio di sensatezza del cosmo. Intervista
a I. Prigogine di Vera Fisogni (www.aparterei.com).
(3): Wikipedia, enciclopedia libera online (www.wikipedia.it).
(4): Pietro Redondi, Epistemologia e storia della scienza,
Feltrinelli editore 1977.
(5): Ilya Prigogine, La fine delle certezze, Bollati Boringhieri
editore 1997.
(6): Giovanni Reale, Platone, www.donatoromano.it, sito di
divulgazione filosofica a cura di Donato Romano.
(7): Alberto Pasquinelli, Il problema dei fondamenti della
conoscenza scientifica, La Chimica nella Scuola 1979.